Gesuita, linguista, grande viaggiatore, missionario, Yves Raguin traccia
in questo volume, nato da un corso che tenne tra il 1977 e il 1982
all'Istituto dell'Estremo Oriente di Taipei, un affresco vasto e
dettagliato delle pratiche contemplative asiatiche, spaziando dal
buddhismo al taoismo, dallo zen allo yoga, dal confucianesimo ad altre
culture ancora. Le via della nuova spiritualità passano attraverso le contaminazioni fra religioni per farne nascere una nuova che, per dirla con Capitini, non preveda credenti ma persuasi non pratichi la carità ma la compresenza.
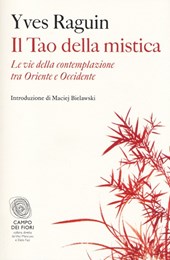
domenica 28 luglio 2013
domenica 14 luglio 2013
Foreste Urbane
Partendo dall'analisi di uno dei fenomeni critici più rilevanti per la capitale, la gestione del ciclo dei rifiuti con l'incombente chiusura della discarica esaurita di Malagrotta, l'architetto Gaetano De Francesco propone come invertire un circolo vizioso facendo rivivere un territorio degradato e deprivato a causa dell'estrazione di materiali per la produzione di calcestruzzo.
I terreni ormai svuotati dall'attività estrattiva sono riportati in equilibrio con il compost prodotto dalla frazione umida dei rifiuti e trasformati in "foreste urbane" cedue. Con il prodotto finale, legname da costruzione, sarebbe possibile invertire il circolo vizioso cava-discarica con un ciclo virtuoso in cui si coniugano un modello di sviluppo sostenibile e nuove strategie architettoniche e paesaggistiche che si inseriscono a buon titolo in una "green economy".
Il lavoro, sostenuto da una consistente base di dati statistici, grafici e documenti, si inserisce in
una collana diretta da Nino Saggio, "The ProActive Revolution in Architecture".
L'intento della collana è quello di proporre una rivoluzione del punto di vista negli studi urbanistici e di architettura: partire dalla crisi anziché da una soluzione.
Le risposte arriveranno, anche per serendipità, grazie alla combinazione delle capacità, dell'intelligenza e della creatività dei progettisti.
Il libro "Foreste Urbane", primo volume della collana, è disponibile in formato elettronico sul sito Lulu.com
I terreni ormai svuotati dall'attività estrattiva sono riportati in equilibrio con il compost prodotto dalla frazione umida dei rifiuti e trasformati in "foreste urbane" cedue. Con il prodotto finale, legname da costruzione, sarebbe possibile invertire il circolo vizioso cava-discarica con un ciclo virtuoso in cui si coniugano un modello di sviluppo sostenibile e nuove strategie architettoniche e paesaggistiche che si inseriscono a buon titolo in una "green economy".
Il lavoro, sostenuto da una consistente base di dati statistici, grafici e documenti, si inserisce in
una collana diretta da Nino Saggio, "The ProActive Revolution in Architecture".
L'intento della collana è quello di proporre una rivoluzione del punto di vista negli studi urbanistici e di architettura: partire dalla crisi anziché da una soluzione.
Le risposte arriveranno, anche per serendipità, grazie alla combinazione delle capacità, dell'intelligenza e della creatività dei progettisti.
Il libro "Foreste Urbane", primo volume della collana, è disponibile in formato elettronico sul sito Lulu.com
venerdì 28 giugno 2013
El especialista del Barcelona
El Especialista de Barcelona è il miglior romanzo italiano degli ultimi dieci anni, scritto dal migliore scrittore italiano vivente. Aldo Busi compie un'operazione semplice nella quale risiede il cui prodest stesso della scrittura. Inventare un linguaggio e grazie a quello, come diceva sanguineti, "letteraturizzare" il mondo. Creare dei dispositivi ambigui, degli enigmi, delle allegorie che lo testualizzi. Compito del lettore critico è non soltanto di svelare l'indovinello, ma di capirne le ragioni, ricostruirne i perchè, valutare l'idelogia letterarie e politica naturalmente) che vi presiede. Nel dialogo dello Scrittore con una foglia la trama scompare, così come scompaiono i ben ventiquattro personaggi intorno cui si avvolge. Contano le digressioni, le invettive, i ragionamenti sul desolato presente che circonda lo Scrittore. Nessuna scrittura contemporanea riesce a rappresentare l'osceno con tanta violenza e leggerezza. L'ipotassi ampia, sinfonica, non estranea alla tradizione, ampiamente frequentata da A.B., si sviluppa su un tono colloquiale, volutamente basso, grottesco, sbracato. Il precedente è nell'Arbasino dell' "Anonimo" e di "Fratelli d'italia", seppure meno composito, meno incline alle citazioni e agli elenchi. I risultato è una lingua non meno potente che assegna allo Scrittore il compito di fornire non tanto il piacere del testo, che pure c'è, quanto i veleni del testo (altra citazione sanguinetiana). Il che vuol dire spingere il lettore verso i sentieri della demistificazione, del rifiuto delle identità fisse, dello straniamento. Il contrario dell'immedesimazione e del coinvolgimento emotivo. Busi riesce a tenere la temperatura della scrittura sempre molto bassa, il che non gli impedisce di provocare incendi e attentare all'odine costituito. L'unica possibilità che lo Scrittore sembra concedere è l'dentificazione nell'orgia liberatoria e sovversiva cui si abbandonano i campesinos messicani nelle spelendide pagine finali del romanzo.
giovedì 13 giugno 2013
"La grande bellezza" di Sorrentino
"La grande bellezza" è un grande film. E lo è perché Sorrentino si pone (e risolve brillantemente) un problema fondamentale: come raccontare la realtà senza che l'autore vi si sovrapponga oppure scompaia in una falsa pretesa oggettività ? Il che equivale a fare del proprio lavoro un lavoro, innanzitutto, di linguaggio. E' il primo passo per evitare il ricorso a moduli narrativi scontati, conseguenza della voglia di mettere ordine, di interpretare, ridurre a moduli ideologici consolidati. Sorrentino ha scelto di rinunciare alla narrazione tradizionale, smontando il meccanismo rassicurante della trama (questa l'eredità felliniana più profonda), per inserire il protagonista e la folla che lo circonda nello spazio de umanizzato di Roma. Il racconto procede per giustapposizione di quadri, come nel mnuovo romanzo del '900 (l'omaggio iniziale a Céline può essere letto anche come allusione al rifiuto del realismo), accumulando suoni, volti, maschere, case prima e dopo le solitarie passeggiate del protagonista. I personaggi non hanno profondità psicologica, non evolvono secondo una pretesa verità dell'autore. Che lavora sui movimenti vorticosi della macchina da presa e sul suono, spesso eccessivo, sgradevole. La parola ha poco spazio, anche Servillo vi si affida con cautela cedendo alla tentazione solo nel fulminante monologo sulla terrazza. Prevale, invece, il suo sguardo scettico che nel corso del film si trasforma in maschera di dolore. Non è né un film su Roma, né sulla crisi italiana che, non a caso, non viene degnata di facili allusioni. Qui si misura la distanza di Sorrentino da banali rappresentazioni mimetiche, come quella del "Caimano" di Moretti. Non c'è nessuna denuncia, nessun senso comune da affermare. L'unica alternativa all'autodistruzione, questo è il tema di fondo del film, è scendere dalla giostra, recuperare consapevolezza. La ripresa di un dialogo con se stessi e il mondo (le radici richiamate dal personaggio di Verdone) che inizi a contrastare il rumore. E allora, come farà Servillo - Jep, forse si tornerà a riveder le stelle. E a scrivere romanzi.
mercoledì 5 giugno 2013
50 anni dal Gruppo '63. L'avanguardia è ancora possibile ?
A cinquant'anni ormai dalla sua data di
fondazione, il "Gruppo'63" continua a suscitare grandi discussioni sia
per le sue teorie che per le sue proposte operative. Così che le istanze
di quel Gruppo continuano a essere pressanti e urgenti ancora nella
situazione attuale per chi non si accontenti della riduzione della
letteratura a fiction e vada alla ricerca di scritture che "facciano
pensare", alimentando l'intelligenza e allenandola per essere pronta
alle sfide del futuro.
Ma oggi è ancora possibile l'avanguardia in letteratura ? E' ancora possibile pensare a scritture non riconciliate al dominio del consumo e dell'intrattenimento ? E' possibile pensare di tornare a cannoneggiare il quartiere generale come cinquant'anni fa ? Sì, se pensiamo all'avanguardia non come movimento storico ma ad una pratica inesauribile della produzione artistica. E allora si tratta solo di trovare i modi e mezzi perché la vecchia talpa della letteratura di ricerca torni a scavare. Magari trovando, oggi come allora, i vari Bassani, Cassola, Moravia da sbeffeggiare.

martedì 28 maggio 2013
L'utopia religiosa di Tartaglia e Capitini
Pubblichiamo un estratto dell'articolo di Paolo Allegrezza, uscito nel numero maggio/13 di Mondoperaio.
Uno dei capitoli meno indagati della biografia di Aldo Capitini, riguarda il rapporto con Ferdinando Tartaglia. Alla loro amicizia si deve, nel '46, la nascita del Movimento di religione, l'esperienza più radicale e ambiziosa scaturita dal fermento rinnovatore dell'immediato dopoguerra. Il movimento scaturiva dal tentativo di promuovere nell'Italia del dopoguerra una riforma religiosa in grado di superare la realtà nella sua dimensione politica, sociale, culturale e, soprattutto, spirituale. Non un ritorno al cristianesimo delle origini, ma il superamento della religione come era stata concepita fino ad allora. Fu una scommessa ardita, al limite dell'impossibile, conclusa con l'uscita dal movimento dello stesso Tartaglia nel '49 e segnata lungo tutto il suo percorso dall'inevitabile isolamento che non poteva non segnare una proposta del genere negli anni della guerra fredda. Da una parte il trionfo delle ideologie, dall'altra Capitini, Tartaglia e un piccolo gruppo di accoliti con il loro sogno di una nuova religione. A dividerli vi erano profonde differenze di formazione ed esperienza. Da una parte Capitini, immerso in quegli anni e sempre più in futuro in un'attività multiforme che non si esauriva nell'impegno religioso, ma si estendeva al pacifismo, alla lotta per l'obiezione di coscienza al servizio militare, alla predicazione non violenta, all'impegno in favore della scuola pubblica. Dall'altra Tartaglia, ex sacerdote colpito da scomunica nel '46, teorico della “realtà nuova”, un'idea di trasmutazione (una delle sue parole-chiave) dell'esistente. Negando l'impegno attivo in politica, in una sorta di temeraria ricerca di un approdo fuori della tradizione. In questa sede non interessa raccontare la storia di Tartaglia o del Mdr, quanto ricostruire il dialogo tra due intellettuali decisamente “irregolari”: estranei entrambi all'inserimento nella schiera, piuttosto affollata nel corso del '900, della dissidenza cristiana o della militanza nel campo della sinistra.
La prima
lettera di Tartaglia a Capitini è del dicembre '44. Contiene
l'invito ad intervenire ad un incontro tra sacerdoti e laici sui temi
del rinnovamento spirituale; Tartaglia,a quella data ancora sacerdote
a Roma, proponeva al suo interlocutore di dirigere la discussione
(F.C., lettera del 26/12/44). Trai due vi erano 17 anni di
differenza. Tartaglia, un sacerdote non ancora trentenne già in
odore di eresia, il filosofo perugino noto, oltre che per la sua
attività antifascista, per essere l'autore di un libro fortunato che
aveva avuto prima della guerra ampia circolazione, soprattutto in
ambienti cattolici (“Elementi di un'esperienza religiosa”).
-->
domenica 26 maggio 2013
Henri Le Saux, il monaco cristiano - hindu
Riportiamo un estratto dalla biografia wikipedia di Henri Le Saux, il monaco cristiano-hindu che in India ha trovato un altro cristianesimo rispetto a quello proposto dalla teologia e dalla chiesa. Vicino alle teorie del distacco di mistici come Meister Eckarth, lontano dalla mitologia biblica.
Henri Le Saux (noto con il nome indiano Abhishiktananda) (Saint-Briac, 30 agosto 1910 – Indore, 7 dicembre 1973) è stato un monacobenedettino francese, figura mistica del cristianesimo Indiano che ha contributo molto al dialogo tra Cristianesimo ed Induismo.
Dopo aver studiato presso il seminario di Rennes entra, a 19 anni, nell'Abbazia di Sainte-Anne de Kergonan, che dipende dalla Congregazione di Solesmes. Ordinato sacerdote nel 1935, assume la funzione di bibliotecario e di professore, prima dello scoppio della guerra nel 1939. Fatto prigioniero nel 1940, riesce ad evadere. Nel 1945, entra in contatto con l'abate Jules Monchanin, dedito agli studi sull'India e alle connessioni tra il Cristianesimo e la spriritualità indiana. Nel 1948, Henri Le Saux raggiunge Jules Monchanin in India. Insieme i due fondano nel 1949 un ashram in un luogo chiamato Shantivanam («il bosco della pace»), sulle rive del fiume Kâverî. L'ashram è dedicato a Saccidânanda, cioè,secondo gli Upanişad,a Brahmâ, Essere, Coscienza, Beatitudine. I due eremiti individuano così una spiritualità della Santa Trinità autenticamente indiana. Dopo essersi recato nel 1949 ai piedi del Monte Shiva Arunachala (a circa 100 km a ovest di Pondichéry) in compagnia di padre Jules Monchanin e avere incontrato Ramana Maharshi, Henri Le Saux è profondamente scosso e cerca di comprendere più profondamente i misteri dell'India senza rinunciare alla propria fede cristiana. Vive un intenso dibattito interiore tra la parte cristiana ed'occidentale e la parte indiana: scrive sul diario «La montée au fond du cœur » alcune poesie che testimoniano questi interrogativi. Dopo qualche tempo passato come eremita sul monte Arunachala Henri Le Saux - che prende dopo il suo incontro con il maestro spirituale Gnanananda Tamil, il nome di Abhishiktananda - inizia una vita errante una parte dell'anno (visita molti monasteri e partecipa alle riunioni interreligiose) e una vita da eremita nella zona di Rishikesh, ai piedi dell'Himalaya, il resto dell'anno. Muore nel 1973, dopo, secondo i suoi ultimi scritti pubblicati in «La montée au fond du coeur», aver avuto un'esperienza di unione con Dio. È sepolto a Indore, India.
Iscriviti a:
Post (Atom)








